Ero al WordCamp di Vienna, a giugno dello scorso anno, quando ho assistito a questo intervento di Sonja Leix: lei è una disegnatrice web di New York. Ha raccontato della sua esperienza di crescita professionale e di come il suo successo lavorativo l’avesse fatta sentire.
Non bene come pensate, al contrario: aver ricevuto un incarico importante, invece che gratificarla, l’aveva fatta sentire ancora più piccola e insicura. Era sicura che se ne sarebbero accorti presto, i suoi nuovi colleghi, che in realtà non era un granché. Che con lei avevano preso un granchio. E poi il coming out durante il WordCamp: sono i sintomi tipici della sindrome dell’impostore.
Quando Sonja ha chiesto alle centinaia di persone presenti in sala, quante avessero vissuto una sensazione di inadeguatezza simile, la maggior parte del pubblico (inclusa io) ha alzato la mano. Bene, molto bene.
Proprio una botta di autostima. Ma anche una rivelazione, un nome da dare a una sensazione che conosco bene da tantissimi anni e che da un anno e mezzo a questa parte è diventata più che una buona conoscenza, direi proprio un’amica.
Quando mi sono accorta di soffrire di sindrome seriamente dell’impostore
Tutto è iniziato quando ho cambiato lavoro e ho iniziato a lavorare da casa, e oltretutto in un ambito nuovo per me.
Con dei colleghi adorabili (e molto nerd), ma seduti dall’altra parte dello schermo. Programmatori, web designer, gente che si dedica al supporto WordPress da anni.
Io tutto il contrario. Nerd del front-end, esperta nell’aprire decine di blog senza seguirli con costanza, poca dimestichezza tecnica ma molta curiosità.
Quando mi sono candidata per questo lavoro, ero motivatissima da queste tre motivazioni principali:
- imparare a fare qualcosa di tecnico sul web
- lavorare da casa
- poter provare l’ebbrezza del lavoro freelance
E quando dopo pochi giorni dalla candidatura sono stata assunta, ho re-iniziato a mangiarmi le unghie come non facevo da più di vent’anni.
Ma puoi essere scema? —mi dicevo. Brava, e ora che ti hanno preso, da dove inizi?
Sia chiaro, io avevo fatto ben presente durante il colloquio che non ero esperta di WordPress, che non sapevo niente di programmazione. Ero stata sincera, sia sui lati negativi che su quelli positivi.
E per i miei colleghi avevano vinto questi ultimi.
Mi hanno accolta nel gruppo, mi hanno istruito, video-chiamato, insegnato le basi, dato coraggio.
Mi hanno insegnato a fare un lavoro che sapevo fare già (supporto al cliente) in un ambito totalmente diverso.
E per quanto in questo anno e mezzo i miei progressi siano stati veramente tanti, e abbia imparato un trilione di cose che non pensavo avrei avuto bisogno di imparare mai, la sindrome dell’impostore è sempre in agguato.
È sua la voce che in quel settembre 2015 mi diceva brava scema, ora sei nei guai.
Sono ancora sue le frasi sussurrate all’orecchio ogni volta che sto scrivendo una domanda per i miei colleghi su Slack:
Ma sul serio hai questo dubbio?
Non è che puoi trovare la risposta da qualche parte senza chiedere a loro?
Come minimo è una roba banalissima e fai la figura di quella che non se la cava da sola.
È colpa sua se quando rispondo a un cliente particolarmente ostico, invio la mail pensando che si tratta di una risposta che smaschera la mia ignoranza o la mia incapacità di gestire il problema.
Quindi sono stata obbligata, a farmi amica questa sindrome. Perché ormai so che quando cerco di combattere contro qualcosa, la tecnica della negazione non mi serve.
È come quando soffro d’ansia e mi si dice “ma non essere in ansia!“.
Cerco di non farlo più nemmeno con le persone che ne soffrono e che sono vicino a me.
Invece che incitare alla negazione del sentimento, ci giro intorno e mi chiedo: cosa mi (ti) crea ansia, esattamente?
Una volta trovato il punto dolente, lo prendo di petto.
È un fattore ansiogeno che dipende da me e su cui ho controllo?
O è un’ansia derivata da qualcosa di esterno che non posso controllare?
Procedere per passi, smettere di negare, andare avanti.
Anche con la sindrome dell’impostore ho fatto qualcosa di simile.
Il punto è che all’inizio di questo nuovo percorso lavorativo, mi stavo letteralmente bloccando.
Andavo avanti a passo di lumaca, frenata dalla costante paura di sbagliare.
Analizzavo anche i problemi più semplici da venti angolazioni diverse, per essere sicura di non aver trascurato nulla.
E nonostante questo pensavo che non fosse abbastanza.
Quando un cliente mi rispondeva ringraziandomi per l’aiuto, il mio primo pensiero era cavolo, dev’essere molto più principiante di me se ha trovato utile quello che gli ho scritto.
Ho scelto allora la strada della convivenza.
Cara sindrome dell’impostore, conviviamo va’.
Tu mi parli e io ti ascolto, ma poi faccio comunque di testa mia.
Allora sono diventata amica della mia sindrome dell’impostore:
Mi sono dovuta sforzare molto per fare questo passo.
Non so se vi ricordate, o se lo facevate anche voi, da bambini: quando c’era un film che vi faceva paura alla tv, vi sforzavate di guardarlo lo stesso. Magari vi mettevate una mano di fronte agli occhi, per poi allargare le dita e guardare di soppiatto lo schermo. Così fino a che la scena paurosa non finiva, e potevate ricominciare a guardare il film come se niente fosse successo.
Io ho iniziato a fare lo stesso sul lavoro: invece che girare intorno al problema del cliente pensando a tutte le cause possibili e a come potevo sbagliare nel rispondere, ho iniziato a fare clic su “invio” quasi chiudendo gli occhi.
Faccio le mie ricerche, formulo una teoria, penso: ok, questa è la prima soluzione che mi viene in mente, e la scrivo.
Se me ne vengono in mente altre, le scrivo. Ma cerco di non rimanere incastrata fra i sussurri della sindrome dell’impostore che mi dice sicuramente stai sbagliando.
Faccio lo stesso anche durante le conversazioni in chat con i miei colleghi.
Quando lavoravo in ufficio, questo problema si poneva molto meno.
Se dicevo qualcosa di stupido, o davo una risposta sbagliata, era molto più semplice rimediare: il linguaggio del corpo facilita molto di più la risoluzione di potenziali conflitti (anche quelli interiori).
Se dici una sciocchezza di fronte a tutti, magari ti metti a ridere e auto-ironizzi.
Se dici qualcosa di palesemente sbagliato, puoi rimediare velocemente scusandoti, e l’espressione del viso potrebbe già essere sufficiente: molto spesso basta anche guardarsi negli occhi per chiedersi scusa, o per notare il pentimento, il rimorso, la vergogna che l’altra persona sta provando.
Quando si lavora a distanza invece, tutta l’espressività facciale non ha più senso.
E non sempre ci sono le emoji giuste per spiegare come mi sento.
Non sempre si trovano le parole giuste per esprimersi al meglio.
Così come è anche facilissimo mal interpretare quello che scrivono gli altri.
Non avete idea di quante volte, quante diomio, nel bel mezzo di una conversazione su Slack con i miei colleghi mi sento male: tipo che mi sento attaccata; o mi sento l’ultima delle ignoranti; o mi sembra che nessuno abbia capito una battuta; o di aver tradotto male un’espressione italiana che in inglese può suonare indelicata.
Mille situazioni di disagio.
Perché quello che si scrive in una chat, rimane lì. Non è come la conversazione orale, che si può correggere, raffinare, mediare con un sorriso o uno sguardo.
Per scrivere e leggere correttamente in una chat di gruppo, senza malintesi, è necessario allenarsi un po’.
Affinare l’empatia. Pensare che gli altri non ce l’hanno con me per partito preso. O che io non sono meglio (o peggio) di loro.
Cerco di evitare di fare confronti, e di prendere le parole degli altri per quello che sono: parole, appunto, non giudizi.
A me ha aiutato moltissimo per esempio pensare che anche i miei colleghi si sentono come me, a volte.
Soli in una stanza a parlare con uno schermo, interagendo con persone lontane migliaia di km.
Penso che anche loro possono essersi svegliati con la luna storta, o insolitamente allegri; possono avere un problema familiare di cui non parlano con nessuno; o aver ricevuto una bellissima notizia, che però non vogliono condividere in ambito lavorativo.
Mi ricordo che così come io ho un mondo nella mia testa, anche per loro è lo stesso.
E che le domande, il dubbio dell’ “avrò capito bene?“, non è una prerogativa mia, ma anche loro.
Quando abbiamo affrontato l’argomento dal vivo, ad esempio quando sono stata a Berlino e ho lavorato a casa del mio collega, o quando ci siamo riuniti per un WordCamp, mi sono resa conto che è una sensazione comune. Che sollievo!
Tutti conviviamo con la nostra personale sindrome dell’impostore.
Ho iniziato a raccontare la mia storia anche dal vivo, in pubblico: parlare di fronte a degli sconosciuti su come ho affrontato la mia amica sindrome dell’impostore è stato terapeutico. Difficile, ovviamente, condita da un’ansia da prestazione a mille, ma molto liberatorio.
Alla fine condividere le esperienze è una delle cose che ci rende veramente umani.
Parlare delle mie debolezze, sia per iscritto che a voce, è un esercizio che mi ha aiutato a capire di non essere sola, di non essere l’unica, di non essere destinata al fallimento solamente perché ho provato a fare qualcosa di nuovo.
—☆—
Tempo di coming out!
In che occasioni si manifesta la vostra personale sindrome dell’impostore?
Ve la siete fatta amica oppure la sopportate a malapena?
—☆—
Foto di copertina: Torino, un anno fa, durante l’incontro con le ragazze di Viaggio da Sola Perché
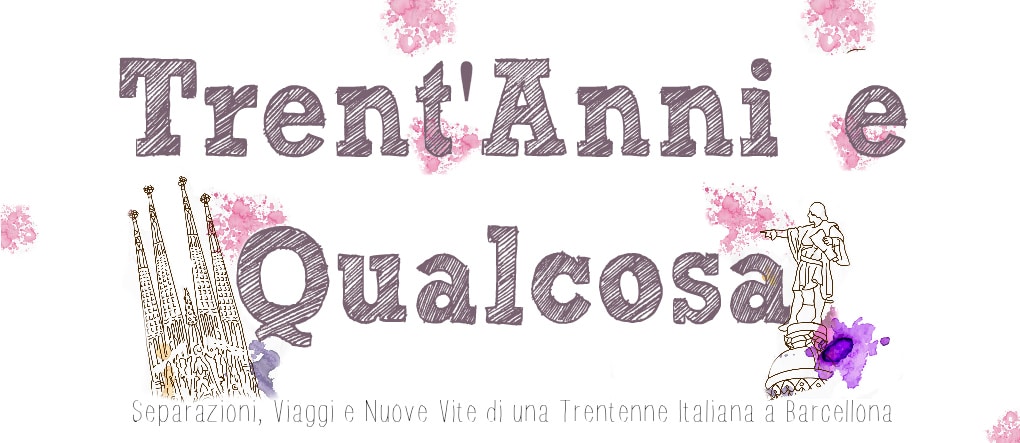
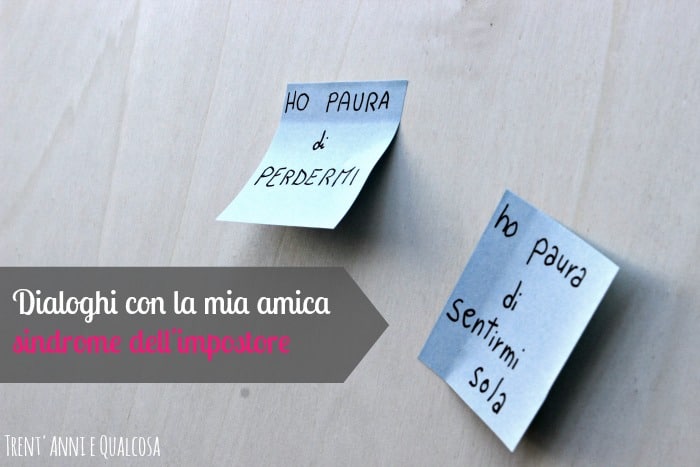
Per chi lavora in Universita’ la sindrome dell’impostore e’ una costante. Durante tutto il dottorato sia io che i miei colleghi eravamo continuamente convinti di essere stati ammessi per sbaglio, che i nostri articoli fossero orrendi e le nostre presentazioni pure peggio. Credo dipenda soprattutto dal fatto che la ricerca accademica e’ spesso molto solitaria e soggetta a moltissime critiche: ogni articolo e’ sottoposto al controllo di altri ricercatori che facilmente lo distruggono. Molto spesso si viene rifiutati da conferenze e riviste e tutto cio’ fa piuttosto male all’autostima. Non ho mai trovato una soluzione alla sindrome dell’impostore, diciamo che vivo serena pensando che se non mi hanno scoperta fino ad ora, non lo faranno mai…Ci avevo scritto un post al riguardo http://giupyincolorado.blogspot.de/2015/04/la-sindrome-dellimpostore-e-del-perche.html
GRazie Giupy, vado a leggere il post allora 🙂
vivo con un ricercatore universitario e ho ben presente cosa significhi far i conti con la sindrome dell’impostore in ambito accademico!
Non credo sia necessario trovare una soluzione alla sindrome, semplicemente come dici anche tu, imparare a conviverci serenamente 😉
Bel pezzo. Io mi sono sentita così prima di iniziare ogni contratto di lavoro negli ultimi anni, e mi sento così ora che devo partire per un progetto in Perù. Ogni volta cerco di calmarmi pensando che se mi hanno scelta vorrà dire che sarò capace di fare tutto al meglio. Eppure rimane, anche ora, quella vocina che mette ansia e ti sussurra all’orecchio “Ma sei sicura di essere all’altezza?”. Negli ultimi lavori ero all’altezza, anzi mi sorprendeva vedermi così brava in azione e mi dava delle piacevoli conferme, la sensazione di essere sulla strada giusta. Ma ad ogni nuovo inizio ecco tornare la sindrome. Allora prendo un bel respiro e mi butto. Basta!
Esatto Vale, diciamo che il verso buono della sindrome dell’impostore è anche sorprendersi poi di come ce la siamo cavate!
In bocca al lupo per l’avventura in Perù, sono sicura che sarà fantastica! 🙂
Cara Giulia, la sindrome dell’impostore è il fil rouge della serie TV, che trovi in Netflix, Suits, ambientata in un ricchissimo e potentissimo studio di avvocati di New York.
Quella è sindrome dell’impostore, non la tua. la frase fondamentale è che tu hai fatto presente, in maniera trasparente, i tuoi limiti. Chi ti ha assunto, ha valutato più importanti gli aspetti positivi. E sia. Te lo dico per esperienza personale, sia perchè quando ho incominciato il mio attuale lavoro non sapevo nulla di cosa volesse dire gestire un’azienda in toto, sia perchè quando io stesso assumo persone valuto come primo aspetto motivazione, flessibilità, capacità di adattamento e soprattutto predisposizione al changemaking.
Quindi per me tu saresti assunta domani mattina!
Sii meno esigente nei confronti di te stessa!
Bravo Stefano, dammi consigli di serie tv nuove che sono a corto di fantasia ultimamente 😉
Lo so, ho un problema di esigenza spinta verso me stessa, da sempre…gli impostori nella testa siamo noi stessi alla fine, no?! Comunque grazie per l’assunzione virtuale, ne sono onorata! 😉
Concordo con Giupi, la sindrome dell’impostore esiste ed è endemica in tutti gli ambienti in cui ti viene ribadito che sei arrivato lì al termine di una accuratissima selezione e nei quali sei continuamente sottoposto a scrutinio.
A meno che il tuo ego non sia così smisurato da pensare che tu sia davvero infallibile sempre e comunque (ci sarà una sindrome anche per questo), tutti noi sappiamo che potremmo sbagliare e viviamo con la convinzione che quel fallimento ci segnerà.
Vado alla Masterclass di un famoso pianista, mi selezionano per il concerto di fine corso, tremo al pensiero che si rendano conto che in realtà sono un disastro.
Inizio la tesi in laboratorio, mi sento imbranata, penso che il prof si pentirà di avermi accettata come laureanda.
Una prof della mia commissione di laurea ha dei fondi e dopo la laurea mi chiede ripetutamente di andare a lavorare da lei, vado e mi sento in ansia al pensiero che tutte le sue fantastiche aspettative su di me si rivelino infondate.
Vinco una borsa di dottorato e passo i primi sei mesi a testare reazioni che non funzionano pensando ogni giorno che i miei colleghi si accorgeranno presto che hanno scelto un’incompetente. Devo continuare?
Secondo me questa cosa è sempre esistita, l’unica differenza è che adesso le abbiamo dato un nome e cognome. Una volta si chiamava ansia da prestazione e si esplicitava in circostanze ben precise, adesso è diventata una sensazione che ti accompagna sempre, ventiquatt’ore su ventiquattro, una condizione esistenziale perché ci viene richiesto di essere “performant” sempre.
La mia tattica di convivenza al momento consiste nel ripetere a me stessa “just good enough”. Era il mantra che un mio amico neuroscienziato mi ripeteva per incoraggiarmi durante la scrittura della tesi: it doesn’t need to be perfect, just good enough. Perché se miro alla perfezione ovviamente fallirò, ma se miro al buono abbastanza, magari ce la posso fare.
Vero Fughetta, un tempo ci limitavamo all’ansia da prestazione, che è forse la madrina della sindrome dell’impostore che come ben dici, ci accompagna sottilmente in molti più aspetti della vita quotidiana.
Just good enough, me la segno 😉
grazie e in bocca al lupo a te!
Oh, quanta verità. Sono d’accordo con Fughetta: le abbiamo dato un nome e cognome tali da farci sentire sempre “malati” e mancanti, in realtà è normale avere sempre da imparare in un lavoro.
Adesso ci sentiamo sotto pressione in ogni momento anche perché le nostre tutele lavorative sono diventate sempre più labili e fumose e sappiamo che al primo passo falso ci potrebbero mandare a casa, e questo contribuisce a farci sentire ansiosi e impreparati.
Per tutto l’ultimo periodo in Svezia mi sono sentita così come tu descrivi: al posto sbagliato, convinta che si fossero sbagliati ad assumermi e che presto si sarebbero resi conto che non ero così brava come pensavano. Avevo un ruolo di responsabilità e le persone che “dipendevano” da me erano tutte più grandi di me. La cosa mi metteva a disagio e mi sentivo inadeguata ed incompetente per la maggior parte del tempo.
E adesso quello che mi ripeto è che “è un problema mio”. Le persone con cui lavoro non hanno alcun bisogno né tempo né voglia di giudicarmi. Di considerarmi inferiore alle aspettative né di scuotere la testa davanti agli scivoloni. Se io mi sento così è solo ed esclusivamente un problema mio, non loro.
Quindi cosa posso fare per migliorare? Non certo essere impeccabile (impossibile), ma verificare perché io mi senta così. E’ mancanza di preparazione? Studiare. E’ mancanza di confidenza con i colleghi o con gli strumenti? Fare conoscenza o impratichirmi.
O è invece mancanza di fiducia in me stessa?
Se è questo il punto, siccome è un “problema mio” solo io potrò risolverlo.
E per trovare soluzioni ci vuole la VOLONTA’. Se io non voglio sentirmi meglio, mi sentirò sempre inferiore, inadatta, inadeguata, un pesce fuor d’acqua.
Mi piace la tua strategia del “farsi amica” la sensazione di inadeguatezza.
Io ho puntato sul darmi dei tempi: se entro un certo orario o un certo giorno non ho prodotto quel risultato perfetto a cui aspiravo, pazienza. Vorrà dire che questo è quello che so fare.
E sull’eliminazione di tutte le con-cause che contribuivano a farmi sentire a disagio: cerco di arrivare puntuale o in anticipo al lavoro, cerco di avere le mie cose organizzate, cerco di rispettare i tempi, cerco di dormire e mangiare bene, cerco di non pensarci quando non sto lavorando e di concentrarmi sulle cose al di fuori del lavoro, quando è sera o è il week end.
Dormo molto meglio la notte.
Un abbraccio!
Ecco, infatti, come spesso accade con gli stati psichici, bisogna sempre lavorare su noi stessi e capire perché pensiamo/agiamo in un certo modo, prima di “dare la colpa agli altri”. Che come dici tu, spesso hanno moooolto meno interesse a giudicare e vederci cadere in fallo di quello che pensiamo. Direi che il sentimento generale è di tranquilla indifferenza, il che è già tanto 🙂
Un abbraccio a te!