Perché non mi hai detto che era un film così bello?
Chiede mia madre al telefono.
Ieri i miei genitori sono andati a vedere “L’uomo che comprò la luna“ di Paolo Zucca, e ne sono rimasti entusiasti. Io l’avevo già visto in anteprima a Barcellona qualche mese fa, durante il Festival del Cinema Italiano.
Anche a me il film è piaciuto, ma mi erano rimasti alcuni punti interrogativi in mente.
L’ho trovato comunque divertente e poetico allo stesso tempo, capace di far leva su un umorismo conosciuto.
Jacopo Cullin, l’attore protagonista, è infatti asceso al successo con delle impersonazioni spassosissime in una delle trasmissioni regionali più famose in Sardegna, “Come il calcio sui maccheroni“ del gruppo comico La Pola.
Il film preme forte quella vena nostalgica che qualunque persona sarda emigrata ha sperimentato almeno una volta nella vita.
La narrazione della Sardegna che ci fa così comodo
Come spesso accade quando si parla di Sardegna, anche in questo film compaiono pianure arse dalla siccità, gregge di pecore placide, azzurri di cielo che cadono sul dorato dei campi, e scorci di mare meraviglioso, di quelli che noi sardi siamo abituati a vivere con naturalezza e gratitudine.
Compaiono anche certi sardi, nella loro rappresentazione forse più famosa e stereotipata.
Sono praticamente solo uomini (c’è solo una donna nel cast, Angela Molina), indossano gilet e pantaloni di velluto, sa berritta, gli stivali con i calzari alti di pelle, e si radunano intorno al bancone degli tzilleri, quei bar di paese spartani su cui troneggiano insegne Ichnusa vecchie di quarant’anni.
È la rappresentazione della Sardegna a cui noi stessi sardi ci adeguiamo con più facilità.
È la nostra comfort zone narrativa.
L’isola inviolata, apparentemente austera, quella che ti guarda muta mentre varchiamo la soglia di un bar e veniamo automaticamente etichettati come forestos, gente di fuori, stranieri (stranieri di paese, non serve venire da lontano).
Ce la raccontiamo e cantiamo in questo modo da sempre, noi prima degli altri.
Salvo poi alzare un sopracciglio quando un foresto vero, non un isolano, si appiglia a quegli stessi stereotipi, imita con esagerazione il nostro accento (come se ne esistesse uno solo) o ci rivela lo stupore nel constatare che la Sardegna è un’isola più moderna di quello che si aspettava.
Lo stesso che succede al personaggio di Cullin quando sbarca in Sardegna e si ritrova nel traffico indaffarato di Cagliari, che di bucolico non ha poi tanto, ed è una città (bellissima) che vive fuori dall’immaginario della Sardegna rurale e pastorale.
Da poco ho avuto uno scambio su Twitter con Paola, che commentava il fatto di non essere un’ammiratrice di Grazia Deledda; anzi, dichiarava apertamente di vederla con una certa antipatia.
Quando le ho chiesto perché, mi ha ricordato come la scrittrice sarda abbia basato la sua fortuna narrativa proprio su un racconto della Sardegna che era più arcaica e immaginaria di quella reale.
E che anzi, cosa che non sapevo, avesse addirittura fatto pubblico il suo rammarico “per il fatto che la Sardegna fosse uscita dallo stato di minorità da cui traeva ispirazione per i suoi racconti.“
Le donne isolate e cupe della Deledda, arroccate nelle loro case sul Supramonte, con le lunghe gonne fruscianti fra le strade di Nuoro o di altri paeselli innominati, i pastori callosi, la natura aspra, hanno contribuito a creare aspettative su un’Isola che già a quei tempi era diversa, in movimento verso la modernità.
Eppure quel senso narrativo vive ancora oggi.

Lo ritrovo nel film di Paolo Zucca, ma anche nella meraviglia cinematografica di “Ballo a tre passi“, con i suoi bambini della Sardegna interna che non hanno mai visto il mare.
(Cosa decisamente improbabile, mi fa notare Paola su Twitter, e io concordo).
Mia madre mi chiede se non mi sia commossa, nel seguire questa storia di isola e di emigrazione (che sconfina anche nell’esilio, con il personaggio interpretato da Benito Urgu).
Sì, mi sono commossa in alcuni punti, ma la parte più razionale di me era lì a chiedersi se questo film non stesse in realtà calcando e rafforzando gli stessi masticati stereotipi di sempre.
E infatti le domande del pubblico catalano alla fine del film hanno un po’ confermato questo timore.
È facile innamorarsi di questa narrazione della Sardegna.
È facile vederne il lato selvaggio, giallo, impervio e romantico.
Io stessa ne ho scritto, e alla fine è spesso quello che cerco quando torno sull’isola.
Ma c’è anche tutto quell’altro pezzo di realtà che conosco bene, e che di paradisiaco ha ben poco.
Si nasconde bene agli occhi dei foresti, eppure esiste: Quirra, le basi militari sparse per la costa, gli scempi architettonici, l’abusivismo.
Parlo con mia madre di tutto questo mentre cammino per le strade di Torino. Ho dormito in un AirBnb in una strada centralissima, calpesto il pavè e mi distraggo in continuazione per via delle vetrine di pasticcini, cioccolati, uova di Pasqua, caffè.
Mi ritrovo a pensare che sarebbe proprio bello vivere qui.
D’altronde le persone sembrano tutte così gentili, distinte, pacifiche, devote al bello e a godersi questa città meravigliosa.
Sono in preda alla mia narrazione, quella che vede gli aspetti belli e pensa a una vita italiana arredata con i miei sogni; niente brutture, niente politica, solo persone interessanti e colazioni al bar da leccarsi i baffi.
Sì, mamma, mi sono commossa, davanti a certe scene del film.
Da emigrata è la Sardegna dell’uomo che rubò la luna, quella che mi manca.
Una Sardegna che si materializza quando ho voglia di sognare un po’.
—❣—
Parlando di isola ed emigrazione:
Deliri da un sardo pomeriggio agostano: le mie vacanze in Sardegna
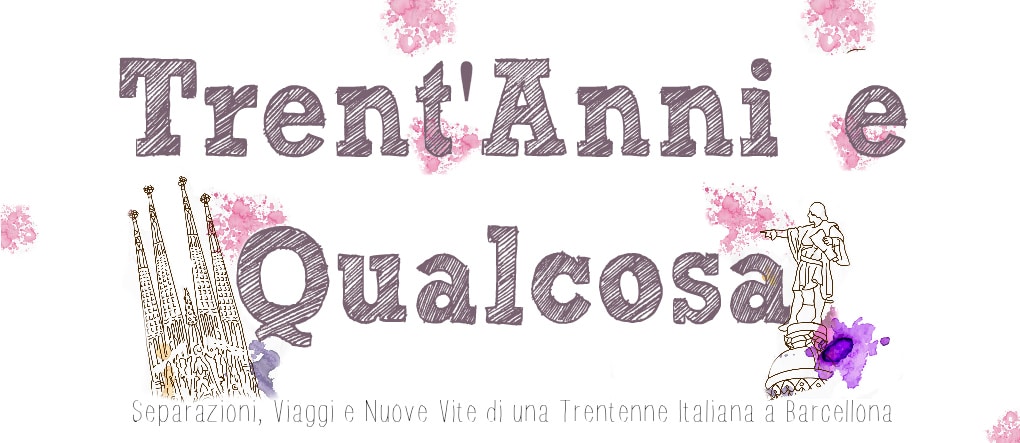

Un po’ mi ci ritrovo con la Puglia, complice il successo dei film di Checco Zalone che, volutamente, marca determinati aspetti dei baresi. Poi arrivi in Puglia o nel barese e ti rendi conto che la realtà è un po’ diversa.
Eppure è quello che viene stereotipato quasi a catturare lo straniero.
Da diversi anni frequento la Sardegna perché il mio compagno è sardo. Barbaricino, che non è un aspetto irrilevante. Di donne con lunghe vesti fruscianti e uomini con sa berritta ne ho visti pochi, ti dirò, meno di quanti avrei voluto vederne. Per me che vivo in una zona della Puglia che ha perso tutti i legami con il passato e la tradizione, è proprio quell’aspetto della Sardegna ad affascinarmi anche se so che l’isola è diversa. Che corre veloce e che nulla ha di diverso rispetto a qualsiasi altra realtà italiana. Così come ne conosco gli aspetti meno idilliaci come le servitù militari.
Eppure è quella Sardegna aspra e austera che mi affascina. Una Sardegna che non è quella degli ajò o degli abiti di velluto con la berritta, ma che ha ancora tanto da raccontare del suo passato.
Ciao Simo, hai ragione, quello della Puglia è un altro esempio attualissimo.
La Sardegna aspra e austera affascina anche me, e per fortuna il legame con le tradizioni e il passato è ancora forte in molte zone dell’isola. Il che è un bene, senz’altro, ma è anche un boomerang che ci fa guardare spesso indietro, invece che abbracciare con fiducia il futuro. La gente dell’isola ha veramente bisogno di fiducia nel futuro, per andare avanti e crescere.
eeeeh mia cara amica, come ti capisco! Tra l’altro condivido la scarsa attrazione verso la Deledda, pur non avendola mai letta, proprio non mi viene neanche da comprare un suo libro 🙂
Appeana de mi ♡
Prendi qualcosa a caso della Deledda e provaci, dai. Quello che ho letto di suo a me è piaciuto; rimane comunque un nodo fondante della letteratura isolana e, anche se guarda molto al passato, rimane una scrittrice da leggere, secondo me. 🙂
Cavoli, io provengo dalla bieca provincia padana, e intervengo probabilmente fuori tema e senza cognizione di causa, ma vi prego, non sminuite la Deledda, i suoi libri sono bellissimi e intensi, io li ho amati da morire. E comunque, così, per la cronaca, il mio preferito è “La via del male”
Ciao Vale! No, no, io non voglio sminuire le opere della Deledda, assolutamente. 🙂
Quello che ho letto di suo in genere mi è piaciuto, come “Canne al vento”, “Marianna Sirca” o “Il Divorzio”.
Però la discussione di cui ho parlato nel post è comunque importante: la citazione che menziono sopra mi fa pensare che la forza narrativa della Deledda risiedeva probabilmente anche nella costruzione del “mito” della Sardegna.