La prima volta che mi sono trasferita in un appartamento che non fosse quello dei miei genitori avevo 19 anni.
Ma vivevo solo a una cinquantina di km da loro, e pur sempre dentro l’isola.
La mia storia di emigrazione inizia nel 2004, quando dopo alcuni mesi di valutazioni, scelgo un’Università fuori dalla Sardegna in cui continuare gli studi.
Il mio primo periodo da emigrata in continente
La prima volta che mi sono sentita un’emigrata avevo 22 anni e una valigia blu da 23 kg con rotelle troppo piccole, che mi ostinavo a riempire come se stessi per affrontare una traversata oceanica.
Dopo averlo tanto sognato, finalmente stavo varcando i confini dell’isola per trasferirmi “in continente”.
Non che avessi particolarmente sognato di sistemarmi in una città italiana, i miei sogni già in quegli anni andavano ben oltre i confini italici.
Ma era un primo passo, già abbastanza difficile da far digerire a mia madre: l’idea che mi stessi trasferendo da sola dall’altro lato del Mediterraneo non le piaceva particolarmente, e per molti (molti) anni ha continuato a non piacerle.
Io invece lo vivevo come un primo passo, e intanto – per sicurezza – avevo riempito la valigia blu con tutto quello che pensavo potesse servirmi nell’autunno continentale.
Come se non dovessi tornare per mesi.
Invece presto mi abituai a una routine di andate e ritorni scandite dai ritmi universitari.
Fra ponti, inizio e fine corsi, festività, chiusure universitarie, tornavo in Sardegna all’incirca ogni due mesi.
Ai miei tempi…
Tutti i servizi che ora ci rendono così facile prenotare un volo online e trovare le offerte migliori, non erano ancora diffusi.
E, soprattutto, la Sardegna non era ancora collegata dalle offerte low cost.
Dovevo far affidamento sulla buona e cara continuità territoriale, che omaggia noi sardi di tariffe fisse per i voli da e per la Sardegna (ma, a quei tempi) solo dagli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino.
Per cui quando dovevo programmare il rientro in Sardegna, la prima cosa da fare era chiamare la mia agenzia viaggi di fiducia, quella del paesello.
Era gestita da un ragazzo più o meno mio coetaneo, con un certo savoir faire che mi rendeva particolarmente piacevoli quelle brevi chiamate periodiche.
Gli dicevo quando volevo tornare, consultavamo gli orari, decidevamo insieme il migliore e poi lui si occupava di prenotarmi il volo.
Naturalmente, quello era solo l’ultimo pezzo del viaggio.
Non ero un’emigrata da grande città, ma studiavo in una cittadina del centro Italia a 3 ore di bus da Roma.
La mia trafila per tornare in Sardegna prevedeva:
- un’alzataccia all’alba
- qualche smadonnamento per portar giù la mia valigia per quattro piani di scale
- altri smadonnamenti e lesioni alle giunture del gomito dovute al trascinamento del mio valigione lungo le stradine acciottolate del centro medioevale
- salire su un autobus per Roma Tiburtina
- prendere il trenino che collegava Tiburtina con Fiumicino
- imbarcarmi sul volo per Cagliari del primo pomeriggio
- arrivare all’aeroporto di Cagliari-Elmas e, finalmente sull’auto dei miei, salire verso il paesello
Un viaggio che, porta a porta, mi prendeva circa 12 ore, ogni santa volta.
Escludendo naturalmente i ritardi aerei, le nevicate invernali che rallentavano il bus, gli scioperi e altri divertenti imprevisti.
In particolare odiavo il rientro. E per un unico imperante motivo: non tanto perché lasciavo l’isola, i suoi profumi o il mio ragazzo.
No, sempre per colpa sua: la valigia blu che mia madre caricava di cibarie e che poi mi dovevo tirar dietro di peso, letteralmente.
Ma capite che era una scelta dettata da spirito di sopravvivenza, visto che ero spiantatissima e i miei lavoretti di traduzione non mi avrebbero permesso di riempire il frigo come faceva mia madre.
Fino al giorno in cui finalmente le famigerate rotelle si ruppero su un sampietrino ed ebbi la scusa per poter comprare una valigia nuova, con rotelle da trolley, di quelle grandi, che rotolano sul serio.
Di quel periodo mi sono rimasti due traumi:
- una lesione alle giunture del gomito destro
- il trauma da “quante cibarie mettere in valigia”
Anche se ora i trolley camminano praticamente da soli, mi ci sono voluti alcuni anni per superare il trauma del peso morto della valigia blu.
Per anni ho litigato con mia madre prima di qualsiasi volo aereo, pensando alla fatica che avrei dovuto fare per trascinarmi 23 kg di bagagli nel mio ritorno in solitaria a casa.
Poi ci si sono messe le compagnie low cost con l’infausto limite degli 8 kg per bagaglio a mano, ma questa è un’altra storia.
Io e i miei amici emigrati da una regione all’altra: le tre sfumature
[Disclaimer: in questo post escludo volontariamente il discorso più ampio e complesso dell’emigrazione all’estero.]
Durante i circa 10 anni da emigrante fra diverse regioni italiane, ho conosciuto tantissime persone che hanno fatto la mia stessa scelta.
All’Università c’era il gruppetto dei sardi, ma non poteva competere in quantità con quello dei pugliesi.
Loro vincevano su tutti, ed è stato così anche negli anni a venire, quando dalla cittadella medioevale mi sono spostata a Milano e dintorni.
I pugliesi erano sempre in maggioranza. In ufficio, alle feste, in fila per l’aperitivo, ai concerti di Caparezza all’Idroscalo.
Ho condiviso con altri emigrati come me molti momenti di studio e ansie pre-esame; li ho conosciuti per caso durante i viaggi in treno e quelli in aereo, sono diventati miei colleghi quando ho iniziato a lavorare.
E questa lunga frequentazione con altri emigrati che, come me, si spostavano da una regione all’altra dell’Italia, mi ha fatto venire in mente che tutti finiamo principalmente in tre grandi macro-categorie, le tre sfumature dell’emigrazione.
1. Gli emigrati nostalgici
Hanno lasciato la loro amata regione pochi o molti anni fa, non importa: parleranno di lei sempre con le lacrime agli occhi.
La maggior parte di loro purtroppo lo ha fatto perché non aveva altra scelta.
Se possono permetterselo economicamente, torneranno comunque a casa ogni volta possibile: ponti, feste comandate, ferie, battesimi, comunioni e cresime.
Se non possono permetterselo, ne soffriranno quasi fisicamente, vittime di una saudade che non lascia scampo.
Per lenire il dolore della lontananza, si circonderanno principalmente di corregionali.
E se ancora non conoscono corregionali nella zona in cui abitano, li cercheranno.
Conosco persone che hanno lasciato il loro numero di telefono sul parabrezza di auto posteggiate nel parcheggio del centro commerciale perché la targa (o un adesivo sul finestrino) rivelava l’origine sarda del proprietario:
‟Siamo sardi anche noi, chiamateci!”
Lo giuro.
Gli emigrati nostalgici, se vengono da una zona costiera, non conoscono vacanze all’infuori della loro regione e non concepiscono l’idea di andare al mare in nessun’altra località al di fuori di essa.
Nessuna regge il confronto per cui è inutile iniziare qualsiasi dibattito sulle spiagge italiane più belle.
Verrete sottomessi alla logica del ‟eh, ma le spiagge di…sono uniche”.
2. Gli emigrati in esplorazione
Gli emigrati in esplorazione sono quelli che hanno lasciato la regione di origine per spirito di esplorazione.
Magari anche per convenienza, un po’ come gli amici nostalgici di cui sopra, ma l’hanno presa con più filosofia.
Si sono detti ‟Ho voglia di novità” oppure ‟Ci provo per un periodo di tempo, vediamo come va”.
Presto iniziano a vacillare fra il profilo nostalgico e l’adattamento, non senza qualche sforzo; ma il risultato è che nel giro di poco tempo inizieranno a sentirsi dei mutanti: sempre più distanti dalle origini e mai del tutto integrati nel posto in cui hanno deciso di vivere.
Vivono in una dicotomia che li fa oscillare fra il rimpianto e l’entusiasmo per la vita nuova, senza sentirsi mai completamente soddisfatti del risultato.
Rimpiangono ad esempio la convivialità e il cibo della regione di origine ma ne odiano il provincialismo; si compiacciono dell’efficienza e della ricchezza di opportunità della città in cui si sono trasferiti ma ne odiano il clima.
Si schermiscono di fronte ai parenti che li prendono in giro, ogni santa volta, con il saluto
‟Ecco i nostri milanesi!” (o torinesi, o continentali, o qualsiasi altro epiteto che marchi una distanza dalla regione di origine, ndr); ma sono pronti a difendere con orgoglio la città che sta dando loro da mangiare, ergendosi soli contro una tavolata di parenti che non si sono mai mossi da casa loro.
Gli emigrati in esplorazione tornano spesso per le vacanze nella regione di origine, ma una vocina nella loro testa continua a ripetere che varrebbe la pena esplorare anche altre zone del mondo.
Fare cioè questa cosa rivoluzionaria: usare le vacanze per quello per cui sono fatte, riposarsi, magari viaggiare, invece che correre fra pranzi, cene e caffè con il parentato.
Molti di loro ingoieranno questa frustrazione senza mai avere il coraggio di annunciare seriamente ‟Cari tutti, quest’anno non torno per Natale”.
E se un giorno troveranno il coraggio di farlo, passeranno un Natale di merda sentendosi in colpa e pagando per qualche mese le conseguenze dell’offesa impartita alla parentela.
3. Gli emigrati adattati
Gli emigrati adattati non hanno di questi problemi. O semplicemente li hanno ormai superati.
Che sia stata la loro forza d’animo o un sano periodo di psicoterapia, sono riusciti a uscire dal loop degli emigrati in esplorazione.
La loro vita nella nuova regione li appaga e mai si sognerebbero di tornare indietro.
Hanno trovato un buon lavoro, probabilmente anche una persona con cui condividere la nuova vita, e vedono il loro passato come un capitolo chiuso.
Ogni tanto tornano a trovare la famiglia, certo che sì; sono adattati mica egoisti (anche se i familiari non la pensano così).
Ma riescono abilmente a dribblare le obbligazioni familiari, non si fanno remore a passare due giorni in famiglia e il resto delle vacanze in viaggio o in una zona di villeggiatura a scelta.
Continuano a tornare a casa con una valigia piena di prodotti tipici che magari distribuiranno in ufficio o fra gli amici, ma senza la paranoia che durino all’infinito.
Hanno infatti fatto pace con l’idea che ormai qualsiasi grande supermercato d’Italia preveda una sezione di prodotti regionali a prezzi abbordabili.
Gli emigrati adattati sono contenti della loro scelta, e lodano la città che li ha accolti.
È possibile che abbiano pensieri simili agli emigrati in esplorazione e sentano di essere ormai troppo lontani dalla persona che erano prima di emigrare. Ma contrariamente agli amici di cui sopra, che si sentono spesso combattuti fra il prima e il dopo, rischiano di cadere nell’estremo opposto, denigrando quello che si sono lasciati alle spalle.
Sono i casi in cui la famiglia di origine non ha tutti i torti a sentirsi allontanata.
Soprattutto quando si vedono tornare a casa un figlio o una figlia che finge di non capire più il dialetto o che fa di tutto per ricordare che ‟dove vivo ora le cose funzionano diversamente”.
Ho avuto colleghi che parlavano con una perfetta cadenza milanese e mai ne avrei dedotto la loro vera origine, se non me lo avessero detto dietro mia esplicita domanda.
Confessione fatta per poi precisare subito dopo, quasi giustificandosi: ‟Si ma vivo qui dai tempi dell’Università, ormai sono più di qui che di là”.
—⭐︎—
Io sono passata per tutte e tre le fasi dell’emigrazione regionale.
Ci sono stati momenti in cui mi sentivo un’emigrata nostalgica il cui unico scopo era lasciare le lande padane per godere del sole della Sardegna. E magari entrare nella schiera di quelli che non fanno che Twittare usando l’hashtag #sardolicesimo, come se la Sardegna fosse l’unica regione in cui valga le pena vivere.
Ho alternato momenti di adattamento, fugaci momenti d’amore per la mia destinazione di emigrazione e rabbia per i confini isolani.
Ma analizzando i miei trascorsi, direi che il più delle volte mi sono ritrovata nei panni dell’emigrata in esplorazione.
—⭐︎—
Se anche voi siete emigrati dalla vostra regione d’origine a un’altra regione italiana, dove vi siete fermati?
O dove progettate di spostarvi?
E a quale delle tre categorie vi sentite più vicini?
Leggi anche:
Una buona ragione per emigrare
Un’emigrante alle prese con quella leggera ansia natalizia: hai presente?
Ode al giorno in cui ho deciso di trasferirmi da sola in una nuova città
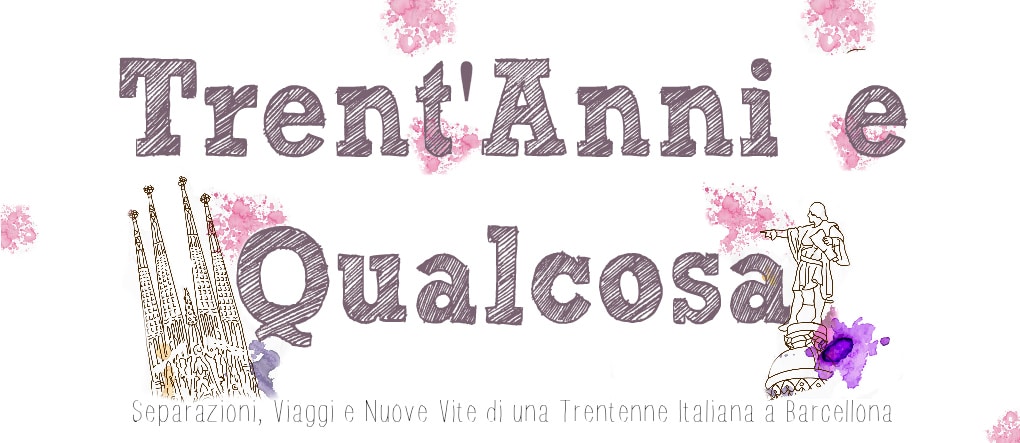

Idem come te, mi sono sempre sentito un emigrato in esplorazione. Anche se ammetto che i primi tempi del mio trasferimento in Veneto sentivo la mancanza delle terre piemontesi che quasi 30 anni mi avevano ospitato, in particolare Torino, quella nuova, quella del dopo-Olimpiadi.
Anche io avevo molti amici pugliesi e devo dire che tra loro ho conosciuto emigranti nostalgici (molti) e anche emigranti in esplorazione. Ma mai emigranti adattati.
E comunque, il problema della valigia strapiena confezionata da mamma è un pezzo di storia di tutti noi!
Io qualche emigrato adattato l’ho conosciuto, soprattutto nell’ambiente degli uffici posh milanesi. Tristezza.